La prima traduzione italiana del Commento al libro di Giobbe di Giovanni Crisostomo
Nel volume n.256 della Collana dei Testi Patristici viene fornita per la prima volta la versione integrale del Commento a Giobbe di Giovanni Crisostomo (introduzione, traduzione e note di Lucio Coco, Città Nuova, Roma, 2018, pp. 256). Si tratta di un testo, probabilmente redatto negli anni in cui era sacerdote ad Antiochia (386-398), che impegna il padre greco in un imponente sforzo interpretativo in relazione ai grandi problemi teologici e spirituali che la sofferenza del giusto e la presenza del male impongono quando se ne voglia cogliere il senso e interrogarne il perché.
Nel raccontare la storia di Giobbe, il Crisostomo, fedele al modello ermeneutico di scuola antiochena, segue alla lettera il testo biblico.

Il libro di Giobbe: il nucleo più antico del racconto
Uomo saggio, venuto prima della Legge, Giobbe era portatore di una religiosità innata che si esprimeva nel timore del Signore, nella cura dei figli, nel rendimento continuo di grazie per i doni ricevuti da Dio. Egli viveva in una straordinaria agiatezza: «Nessuna sollecitudine proveniva dall’esterno, nessun problema dall’interno; godeva di una pace profonda. C’era armonia tra i figli, il bestiame prosperava, nessuna guerra si avvicinava; nessun conflitto in casa, nessun combattimento interno e esterno lo rovinava» (1,14).
Tuttavia a un certo punto questo equilibrio si rompe e comincia l’altra storia di Giobbe, quella che tutti conoscono e che è rimasta proverbiale: quella dell’uomo che ha perduto tutto, i beni, i familiari, la propria salute con il rischio di rimetterci anche la vita. Il paesaggio che si dischiude è davvero tragico: «I campi sono deserti, il bestiame distrutto, la terra non dà frutti, dovunque si sentono lamenti, gemiti risuonano nelle case, tutto ormai è affidato al caso, di tutto si è fatto razzia. Che guerra, che battaglia, quale saccheggio si è introdotto così nella casa del giusto? Che cosa si deve dire?» (1,26).
Eppure su questo scenario di devastazione e di morte si levano come un suggello della sua fede in Dio le parole di Giobbe che manifestano quanto egli fosse irreprensibile anche nel momento difficile della prova: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò» (Gb 1,21). E più tardi, quando lo colse la malattia del corpo, egli ha ancora parole che assolvono e giustificano: «Se da Dio, dice, accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?» (Gb 2,10). Commenta puntualmente Giovanni Crisostomo, volendo trarre un insegnamento per il lettore: «Non addoloriamoci dunque del fatto che soffriamo senza meritarcelo. Soprattutto perché Dio era padrone di dare anche solo i mali. Se ci ha dato anche dei beni, perché ce la prendiamo? Vedi come in nessun caso Giobbe parla di peccati o di buone azioni, ma dice solo che è possibile che Dio faccia ciò che vuole. Ricordati la felicità di una volta e non dovrai faticare a sopportare le difficoltà presenti. Basta, a nostro conforto, che sia il Signore a mandarcele. Non parliamo di giustizia o di ingiustizia» (2,15).
Il secondo nucleo narrativo del libro di Giobbe: i «medici molesti»
A questo racconto iniziale, che costituisce il nucleo più antico del testo biblico, si aggancia una seconda narrazione che trae nuova linfa dall’arrivo degli amici di Giobbe, Elifaz re di Teman, Bildad sovrano di Suach e Sofar re Naamà, e più tardi di Eliu il Buzita. Costoro, uno per volta e con ampie digressioni, interloquiscono con il sofferente. Tuttavia, più che confortare, essi si rivelano come «medici molesti» (Gb 13,4), le loro parole infatti, viene spiegato, «non solo sono prive di consolazione ma ispirano anche un grande abbattimento e sviluppano lunghi discorsi di accusa» (4,1). Interessante è il disegno sotteso al libro che al Crisostomo interessa mettere in evidenza. Gli argomenti infatti che ciascuno di loro porta sono quelli della teologia classica sulle ragioni del male e della sofferenza: i benefici che derivano all’uomo dalla sofferenza (Elifaz); la prova come una verifica della santità del giusto (Bildad); il tema dell’incomprensibilità di Dio (Sofar), sul quale torna in seguito anche Eliud che sottolinea la sproporzione tra l’intelletto umano e il logos divino, quando si tratta di indagare il perché delle cose con l’invito a «non cercare di capire il giudizio di Dio» (34,4).
Giobbe visto e lodato dal Crisostomo
Giobbe però rifiuta queste «teologie». Nel commento il Crisostomo enfatizza la scelta di Giobbe di andare oltre gli argomenti e le interpretazioni umane e interrogare direttamente Dio, presentandosi davanti al suo tribunale: «So infatti ciò che ho detto; nondimeno non mi asterrò dal parlare a Dio, a Dio che conosce i segreti del mio pensiero. Meglio sarebbe, dice, essere giudicato davanti a Dio che davanti a voi» (13,2). Ne segue un processo immaginario in cui Dio è tratto fuori dal suo silenzio ed è chiamato a rispondere perché non bastano più le teologie degli amici che Giobbe ha puntualmente smontato. In questo colloquio Dio gli fa vedere la natura, il cosmo e il mondo animale, con le loro leggi ben regolate e i comportamenti altrettanto ordinati manifestano «la sapienza di Dio» (38,3) e la provvidenza che regola il tutto (38,12). Ne discende la conclusione del Crisostomo, improntata alla lezione del Signore, che se Dio si dà tanta cura per ogni cosa inanimata e per ogni essere animato «quanto più se ne darà per l’uomo» (38,81). Eppure neanche questo è sufficiente a sciogliere il paradosso della sofferenza di Giobbe. E’ necessario un altro passaggio agli occhi del Padre della Chiesa che la possa pienamente motivare, ovvero quando Dio afferma che ha mandato queste sofferenze a Giobbe «se non altro perché egli sembrasse giusto» (Gb 40,2). E’ questo l’argomento conclusivo che il Padre della Chiesa ricava dal discorso di Dio per interpretare il senso della sofferenza di Giobbe. La prova serve a Dio per dimostrare che Giobbe è giusto non per condannarlo. A questo punto il commento del Crisostomo si può avviare alla sua conclusione: la presenza del male è un fatto del mondo ma Giobbe insegna come rispondere al male e quale atteggiamento tenere di fronte ad esso. Alla radice di ogni sua scelta e di ogni suo comportamento c’è solo una forte fede in Dio, che lo fa prescindere dalla contingenza anche drammatica e contraddittoria nella quale si trova immerso. In questo consiste il suo essere «giusto», paradossalmente, nel non esprimere un giudizio ma di accettare tutto con fede. Il Boccadoro ha parole ancora più chiare: «Il bene più grande e la più grande sapienza è venerare Dio e non affaticarsi nell’esprimere un giudizio né chiedere conto degli avvenimenti. Non crediate di trovare un’altra sapienza» (28,3). E’ questa la chiave, forse la più importante e segreta, che il padre antiocheno ritrova nel testo del Giobbe per accettare il dolore senza escludere Dio, anzi per assumerlo nella sua luce tanto che al termine di questo percorso di verifica della propria fede quel «giusto» può esclamare: «Prima con l’orecchio ascoltavo ciò che si diceva di te, ora invece ti ho visto con gli occhi» (Gb 42,5).

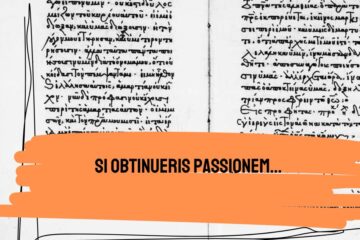

0 commenti